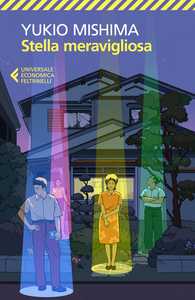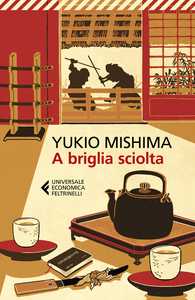“‘La bellezza,’ ripresi, “le cose belle, sono ormai miei nemici mortali.’”
Un giovane monaco buddhista, deforme e balbuziente, dà fuoco al padiglione del Kinkakuji, tra i più importanti santuari di Kyoto. Partendo da un clamoroso fatto effettivamente verificatosi nel 1950, Mishima narra la vicenda con aderenza alla cronaca, ma arricchendola di profondi risvolti umani e filosofici, che fanno di questo romanzo un vero e proprio capolavoro, riconosciuto da molti come la prova migliore dell’autore giapponese. I pensieri del giovane Mizoguchi, progressivamente dominati dall’idea del tempio che diventa per lui l’ideale supremo di bellezza e quindi l’unico oggetto dei suoi desideri, lo spingono a sviluppare un’autentica ossessione dalle conseguenze terribili, le cui radici si possono spiegare in molti modi: come esito dell’infanzia infelice in cui Mizoguchi ha dovuto portare il peso dei propri difetti fisici per esempio, o come una metafora di quell’attesa quasi magica della distruzione che si abbatté sul Giappone nelle fasi finali della Seconda guerra mondiale. Ma, al di là di queste interpretazioni, il romanzo di Mishima si presenta come una grande parabola giocata sugli insegnamenti del buddhismo zen: perché distruggere il tempio altro non è che l’unico modo per salvaguardarne la bellezza suprema, per liberarlo dalla costrizione della materia e impedire che il tempo lo corrompa.