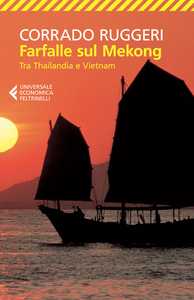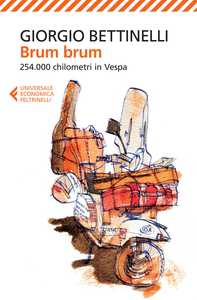"Dove andate?" Istanbul. Confine di Trieste, ore 16, vento di Nordest. Il poliziotto sloveno confronta i ciclisti sbucati dal nulla con le foto segnaletiche sui loro passaporti. Altan Francesco, 58, vignettista. Rigatti Emilio, 47, professore. Rumiz Paolo, 53, giornalista. I tre matti in mutande aspettano davanti all’autorità costituita, si godono l’effetto della loro risposta demenziale. Sanno che l’uomo in divisa deve calcolare in fretta molte distanze anomale. Primo, tra la lentezza delle bici e la lunghezza della strada, duemila chilometri. Secondo, fra la rispettabile maturità dei viaggiatori e le loro sacche da globe-trotter. Terzo, tra la nobiltà della meta finale e la miseria che c’è in mezzo, i Balcani. Ma soprattutto l’uomo deve inghiottire il dislivello fra la propria domanda di routine e quella risposta fuori ordinanza, scodellata con perfido understatement. "Istanbul" come dire Treviso, Udine, Lubiana. "Siamo curdi che tornano a casa." Emilio rompe il silenzio, dimentica che le stellette hanno poco senso del humor. Ma gli va bene, il "Witz" buca la divisa, il poliziotto sorride e si decolla leggeri verso le foreste della Slovenia, imboccando all’incontrario il corridoio dei clandestini, dal confine più colabrodo d’Europa alla stazione centrale dell’emigrazione asiatica. Ci andiamo apposta, alla faccia del nostro onorevole ministro dell’immigrazione. Addio Occidente, ristorantini, strade liscie, mousse au chocolat. Si va a Oriente, da dove la gente scappa. Alla faccia di Bossi e del piscio di porco, di Berlusconi e dei manganelli genovesi, noi cerchiamo la feccia d’Europa. Bulgari, zingari, serbi, popoli delle polverose latitudini extracomunitarie. E ci chiediamo se usare così la nostra bici non sia una cosa anarchica, antiglobale. Dunque di sinistra.