Gianfranco Bettin risponde al questionario di ‟io donna"
Gianfranco Bettin si sottopone alle domande del questionario liberamente ispirato al famoso gioco di Marcel Proust.
Lo Stato sociale diventa global. Intervista a Jean-Paul Fitoussi
‟Nell'Ue, si è optato per il sistema che chiamo del "dittatore benevolo". I governi, cioè, non hanno più i mezzi per agire perché ogni tentativo urta con i vincoli posti dall'alto. Le scelte economiche sono predeterminate dalle regole. Dunque, è stato ridotto lo spazio della democrazia. I governi di destra che cercano di abbassare le tasse, oggi non possono più farlo. Lo stesso avviene per quelli di sinistra che vogliono aumentare la spesa pubblica. Si riduce la spesa sociale, poi, nel momento in cui si ha disoccupazione di massa.”
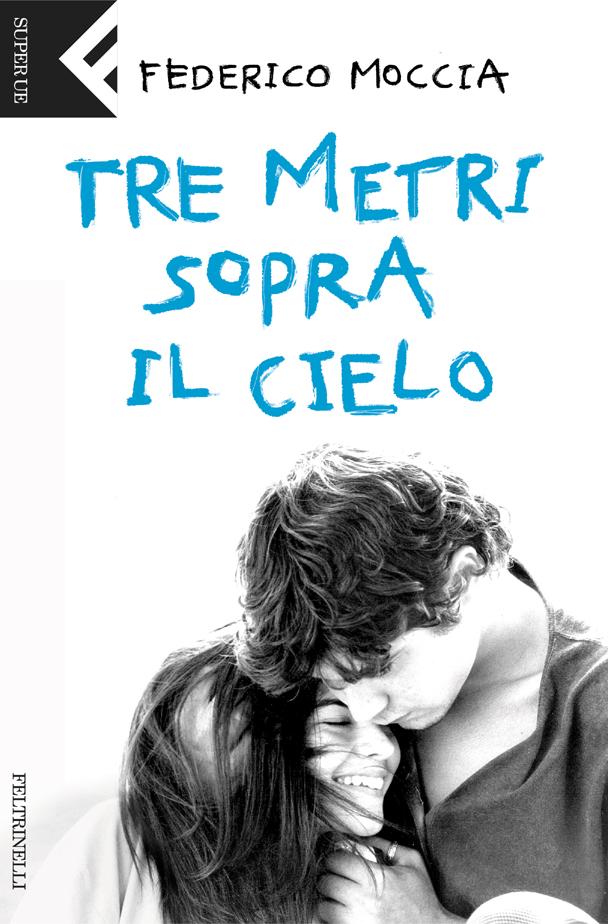
Ho trovato il mio posto al sole volando Tre metri sopra il cielo
‟Che cosa mi viene in mente se penso alla, parola estate? Be , una bella birra fredda. Chiara. Poi un'insalata caprese. Che profuma di basilico. L’uva e i fichi (qualche volta, da piccolo, li rubavo). E il vitel tonné, quello fatto da mia nonna materna Elisa, un'ottima cuoca. Più brava di lei c'era solo la zia Maria, la sorella del nonno. Ma l'estate per me, per tanti miei coetanei, per i protagonisti del mio romanzo, Tre metri sopra il cielo, è soprattutto mare. Pieno di fascino e di mistero, è il luogo dell'amore e del dolore; è il luogo della creazione artistica e del riposo; è il luogo dei ricordi e dei sogni." Federico Moccia ha compiuto 41 anni il 20 luglio ma ha l'aria, e il cuore, dell'eterno ragazzo. È sposato da tre anni con GiuIia, 32. Per ora non hanno figli, ma lui è diventato una sorta di guru, di "padre spirituale" di schiere di giovani lettori. Lo incontriamo sulla spiaggia romana di Fregene, al Villaggio dei Pescatori. È una mattina calda, ma c'è una brezza leggera che mitiga l'afa. Chiacchieriamo come due amici camminando sulla sabbia.
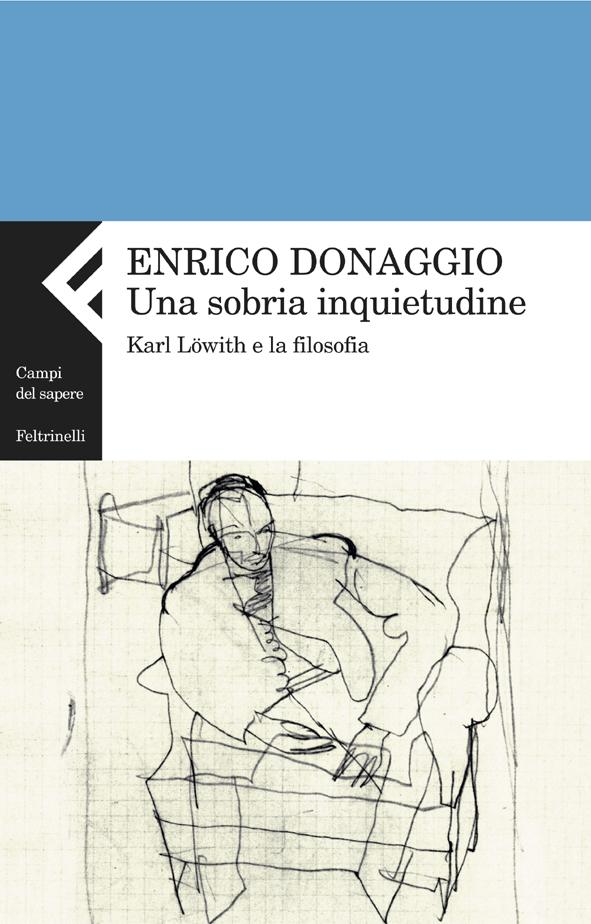
Enrico Donaggio presenta Una sobria inquietudine
Wittgenstein ha detto che esistono pensatori che sono come delle vette e altri che sono invece simili ad altipiani. Löwith appartiene senz’altro a questa seconda categoria: studiandolo non ci si inerpica su cime tempestose, ma si vedono molte cose da una prospettiva meno estrema e unilaterale di quella che si gode da un picco solitario. Leggendo i suoi libri si entra in contatto con quanto di meglio la filosofia europea ha prodotto nei due secoli che ci siamo lasciati alle spalle. E non lo si fa nel modo solipsistico, spesso arrogante, di chi si ritiene il depositario esclusivo di pensieri elevatissimi o abissali. Si apprende piuttosto un’arte dei toni sommessi, un approccio mimetico che mira a restituire una polifonia di voci alle quali, in modo discreto quanto deciso, Löwith aggiunge la propria. Questa trama di confronti – con Hegel e Nietzsche, Marx e Weber, Heidegger e Schmitt – nasconde infatti nella sua filigrana una critica alle responsabilità politiche della filosofia e una critica integralmente filosofica della modernità occidentale. Un tentativo, se si vuole, di sopravvivere filosoficamente al Novecento.

